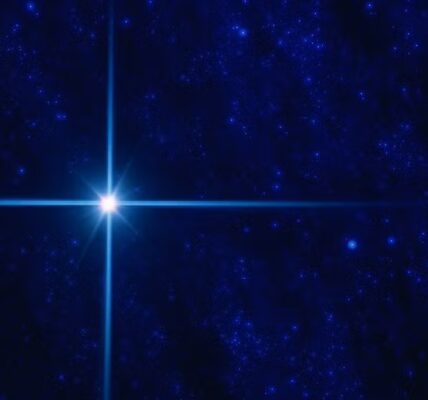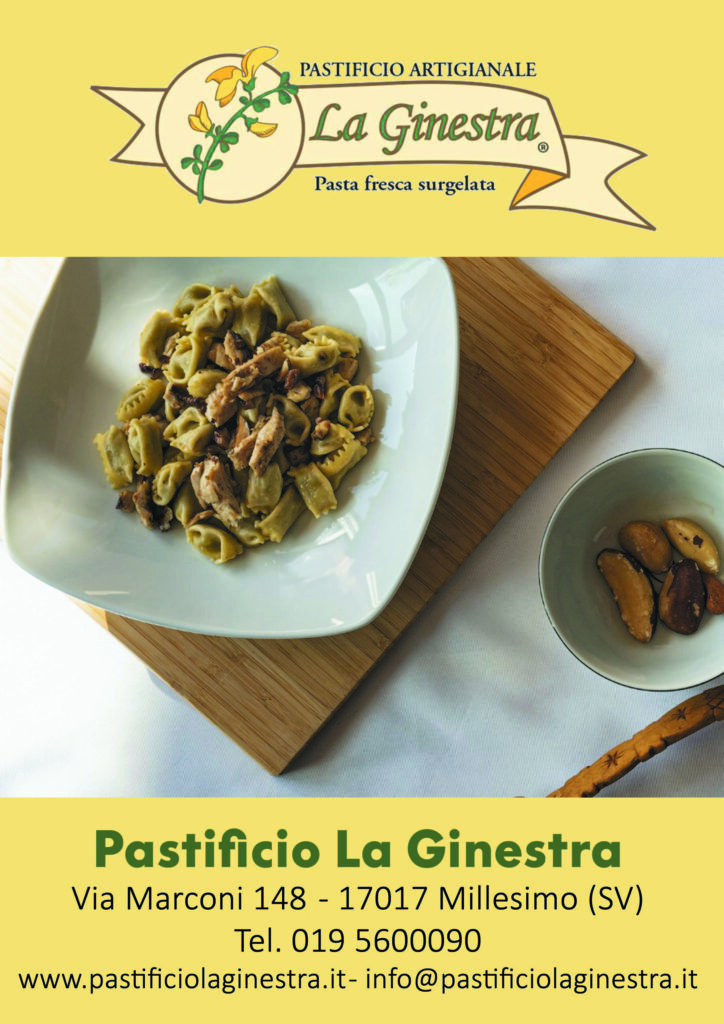di Antonello Catani
Nec fuerat nudas poena videre deas.
Properzio, Elegie, III.13.
1. Rappresentazioni proibite
All’inizio di una sua famosa novella, parlando delle profonde radici che, nella vita degli uomini, hanno “le belle storie su cui sono costruite le grandi opere di poesia”, Gottfried Keller, gloria della letteratura svizzera moderna, osservava che “Il numero di queste storie è limitato, come quello dei metalli, ma esse di continuo si rinnovano in circostanze mutate e nei travestimenti più strani.1
Rinnovamento, mutamento, travestimento… Sia pure indirettamente, Keller stava qui fissando alcune caratteristiche essenziali dell’immaginario, le cui maschere sembrano infatti inesauribili, come se non vi fossero nè limiti nè confini al registro della finzione.
Ma è veramente così? In realtà, per lunghi periodi, nè quel registro fu così ampio nè quelle maschere furono così libere come la loro inesauribile varietà sembrerebbe suggerire. Il mito e l’epopea antichi, per esempio, soggiacevano a tutta una serie di canoni, di schemi, di vincoli formali o socio-religiosi, che in qualche modo ne limitavano la gamma dei contenuti o ne riducevano le piene capacità espressive. La maggior parte delle loro storie hanno un tono paradigmatico e hanno quasi sempre al centro figure divine o semi-divine. Anche quando l’accento si sposta su dei semplici protagonisti umani – vedi Ulisse – è difficile a questo proposito non condividere l’opinione di Auerbach, secondo cui l’individualità di tale figura è per così dire irrigidita in un presente senza tempo. Del suo ‘divenire’, cioé, come anche di quello di Penelope, del mutamento del suo aspetto fisico col trascorrere degli anni, insomma, non vi è traccia.2 Il tipo prevale sulla varietà del reale, l’evento emblematico sul particolare quotidiano. Analoga attitudine ricompare nella letteratura medioevale, in particolare nella canzone eroica francese (Chanson de Roland, etc.), riguardo alla quale, sempre lo stesso autore, faceva notare come essa rappresenti “soltanto una parte della vita oggettiva”, e come il suo scenario sia limitato allo strato sociale alto della società feudale.3 Bisognerà attendere la metà del XIX secolo, e in particolare Flaubert – osservava ancora Auerbach – per iniziare a percepire nella finzione narrativa un attitudine realistica, e cioè, la disponibilità a rappresentare ceti socialmente inferiori e, soprattutto, “avvenimenti qualsiasi e d’ogni giorno”.4
3 maggio 2025
1 Cfr. G. Keller, Giulietta e Romeo nel villaggio (tr. Anna Rosa Azzone Zweifel), Venezia, 1992, p.57.
2 E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, I-II. Torino, 2000; vol. I, pp. 20-21.
3 Ibidem, vol. I, p. 134.
4 Ibidem., II, p. 266.
2. Continua