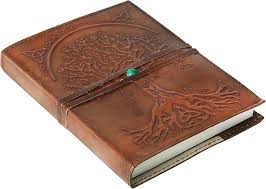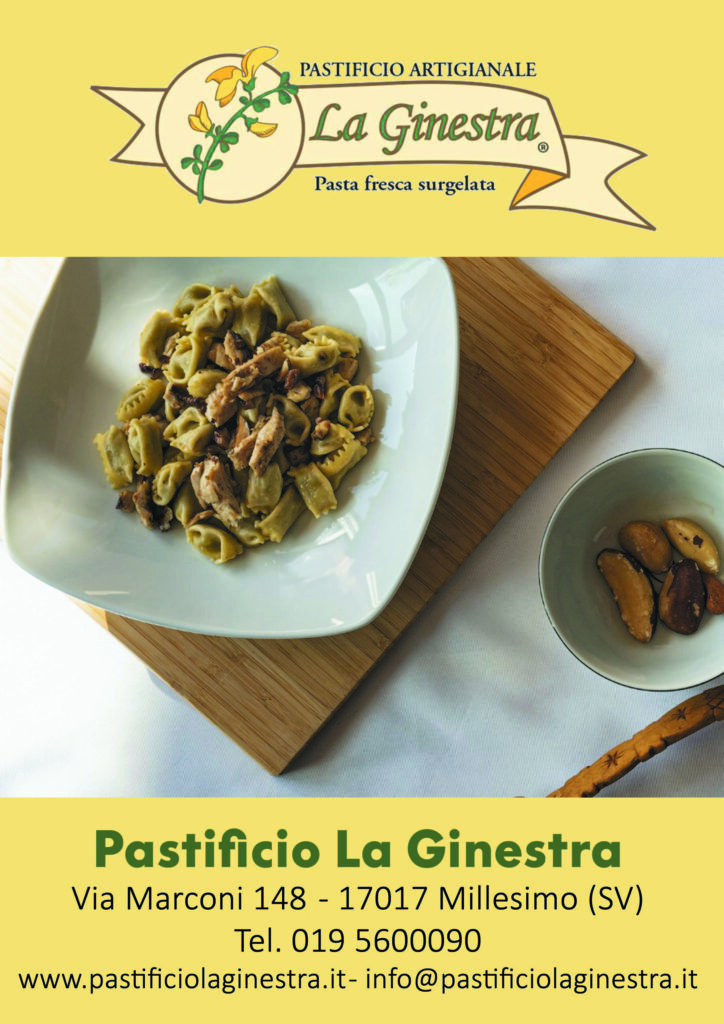di Agostino Roncallo
Ho conosciuto Gattino una sera d’estate. Gli amici mi avevano detto “oggi andiamo in Val Maira” e io, avevo aderito con entusiasmo all’idea. La Val Maira è una delle “vallate occitane”, così chiamate perché afferenti all’Occitania, un territorio che fin dal medioevo possedeva una cultura e una lingua, il franco-provenzale, transnazionali. Se lo spartiacque delle Alpi Marittime, lungo il quale corre la linea di confine, divide francesi e italiani, la lingua li unisce. La valle è anche una delle cinque raggiungibili da Cuneo ma, a differenza della Valle Stura o della Val Vermenagna, è chiusa e priva di valichi di confine. E al fondo, dove quel mondo finisce, c’è Chiappera, l’ultimo centro abitato, sovrastato da due cime aguzze che incombono, come austere sentinelle, sul villaggio: la Torre Castello e la Rocca Provenzale. Qui ho incontrato Gattino. La sua era l’ultima casa del paese: superarla significava entrare in un territorio disabitato che conduceva in fondo a quell’anfiteatro montuoso, dove il piano finisce e inizia la montagna. Allora si sale per luoghi apparentemente inaccessibili che solo a distanza ravvicinata rivelano un passaggio scavato nella roccia a prezzo di chissà quali sacrifici. Tale è la salita che conduce alle cascate dello Stroppia. Si incontra un rifugio, anch’esso chiamato Stroppia dal nome del torrente e delle cascate che lo sfiorano, e poi un bivacco, il Barenghi. Oltre c’è il confine, si entra in territorio francese.
Sull’abitazione di Gattino era appesa un’insegna scolpita su legno: Provenzal City. La sua non era in effetti una semplice abitazione ma un luogo di ritrovo, dove si poteva mangiare, dormire e perfino ballare. Sì perché, all’interno di quella vecchia casa di pastori in nuda pietra all’esterno come all’interno, Gattino aveva ricavato una cucina, una sala comune e, nella stalla, tra le mangiatoie, una rudimentale discoteca, fatta di primitive luci colorate e di un altrettanto improbabile impianto stereo. A vedere tutto ciò noi ridevamo impietosamente. Ma Gattino, dicevamo, chi mai verrà qui a ballare, in un ambiente così freddo e umido, in mezzo alla paglia, residuo ultimo della stalla di un tempo? Quando si balla ci si scalda, rispondeva lui. Era un vecchio dalla barba bianca, folta, e la sapeva lunga: era anche fotografo, musicista, e aveva una particolarissima filosofia di vita che raccontava a tutti i visitatori fin dal 1968, anno di apertura del locale. Già al primo incontro era inevitabile salutarsi da vecchi amici, come se ci si conoscesse da sempre, ciao Gattino come stai? Ci si sentiva così bene che alcuni, già al primo incontro, entravano in confidenza: ehi Gatto, come va la vita? E giù, pacche sulle spalle. Potevano passare anni ma lui ricordava tutti i volti, e i nomi di chi aveva ospitato, la sua memoria era impressionante. Un tempo ero convinto che “Gattino” fosse un amichevole soprannome e solo anni dopo mi resi conto che si trattava in realtà del cognome. Per esteso, lui si chiamava Giovanni Gattino. Credo in verità che nessuno avesse consapevolezza di usare il cognome, Gattino è una di quelle parole che contengono affetto indipendentemente da ciò che nella realtà rappresentano. Una sensazione analoga la ebbi leggendo su una cartolina di inizio secolo i baci che un tal Volpino Carluccio mandava alla fidanzata. Ignoro se si chiamasse davvero così, so solo che non lo avrei immaginato con un nome diverso.
Nel corso degli anni andai da Gattino in diverse occasioni, che si trattasse di fare una salita alpinistica o una semplice escursione con amici, ogni motivo era buono per andarlo a trovare. Ogni volta si consumava un pasto tutti assieme e se nel frattempo arrivava qualcuno, lo si faceva accomodare al tavolo comune. Chiunque poteva usare la cucina. Alcune sere suonava il piano e noi lo accompagnavamo col canto. Erano serate calde, conviviali. Al momento di partire ognuno lasciava dei soldi per i pasti e i pernottamenti, ma non c’erano tariffe, né registratori di cassa o ricevute fiscali, semplicemente ognuno lasciava quanto sembrava opportuno lasciare. Gattino scriveva anche musiche che sarebbe azzardato definire belle. Lui però ne era entusiasta: ricordo che un giorno raccontò di avere avuto un ospite importante, uno degli organizzatori delle olimpiadi invernali che quell’anno si sarebbero svolte nella vicina Francia. Quell’ospite gli disse che avrebbe voluto usare una delle sue musiche come sigla televisiva. Nessuno seppe quanto di vero ci fosse in quella promessa e in quel racconto. Che cosa ci faceva l’organizzatore di una olimpiade in una valle sperduta sulle alpi, ignorata dal grande turismo? Gattino era anche un bravo fotografo e mi piaceva osservare le fotografie che aveva appeso alle pareti. Una raffigurava il volto di una bellissima donna sorridente che aveva in testa una specie di colbacco. Mi chiedo tuttora chi fosse, dai tratti del viso avrebbe potuto provenire dall’est, credo anche di averglielo chiesto: Gattino, chi è questa bella ragazza? Rispose, ma il ricordo è confuso, che si trattava di una fidanzata di gioventù.
Poco prima di Chiappera, c’è una località il cui nome, Acceglio, proviene probabilmente dal latino “ad cilium”, nel senso di “posto in alto”. Nel 1983 andai lì in qualità di educatore con una colonia del Comune di Genova. Era il mio primo anno di università ed ero ben felice di guadagnare qualcosa che mi avrebbe permesso di essere indipendente e acquistare i libri che desideravo. Il nostro ruolo, per la precisione, non era quello di educatori ma di “monitori”, un termine che fino ad allora mi era sconosciuto e che aveva come sinonimo quello di “controllore”. Chi si doveva dunque controllare? La colonia del comune era pensata per ospitare bambini e ragazzi nella fascia che va dagli otto ai quindici anni, provenienti dalle famiglie più povere della città. La retta pagata da tali famiglie era veramente irrisoria mentre il nostro stipendio era davvero dignitoso. Il mio entusiasmo nasceva dalla possibilità di passare tre mesi in montagna, in una valle dove ero già stato e che avrei potuto conoscere meglio dal punto di vista escursionistico. Non potevo immaginare, in quei giorni, la disastrosa situazione in cui sarei venuto a trovarmi.
Che qualcosa non andasse per il verso giusto si intuiva già nelle prime riunioni organizzative: la pattuglia dei monitori era assolutamente raccogliticcia, erano persone provenienti dagli ambienti sociali più disparati che non conoscevano la montagna e le problematiche ad essa connesse. Si andava da un gruppo anarchico militante in Autonomia Operaia, che era extraparlamentare, ai religiosissimi “focolarini” del gruppo di Comunione e Liberazione. Come quelle persone fossero state selezionate è rimasto un mistero. Io ero lì perché Francesco, un amico del club alpino che già l’anno prima aveva fatto quell’esperienza, mi aveva detto: dai, tu che conosci la montagna, hai una splendida opportunità. E io avevo risposto: perché no? Fu così che Francesco segnalò il mio nominativo agli organizzatori e io venni così prescelto in qualità di monitore.
La prima riunione fu tragicomica: il responsabile della colonia, un personaggio dallo spirito tanto avventuroso quanto scriteriato, ci spiegò che noi monitori avremmo dovuto costruirci, con assi di legno che il comune ci avrebbe inviato, delle baracche in cui vivere quei tre mesi. Bambini e ragazzi sarebbero invece stati ospitati in tende e roulotte. Ma noi non abbiamo mai prima d’ora costruito una baracca! – dissi. E allora? – fu la risposta. Non aggiunsi nulla, si rischiava per passare per disfattisti. A giudicare dai volti perplessi delle persone che mi circondavano, era probabile che tutti avessero un comune pensiero che si può così sintetizzare: siamo ben pagati, il resto cosa importa? Quando saremo sul posto faremo quel che ci diranno di fare.
Iniziammo così un percorso di formazione che comprendeva dei laboratori che si svolgevano nel suggestivo ambiente di Palazzo Ducale, antistante alla centrale Piazza De Ferrari. Io scelsi il laboratorio musicale: un etnomusicologo, armato di registratore audio a tracolla, ci portò in giro per la città per registrare rumori che poi avremmo dovuto analizzare. L’idea era interessante, mai avevo percepito che la città potesse contenere suoni tanto diversi, ma avevo anche un dubbio: a cosa poteva servire quell’esperienza? A niente, ma questo forse, era scontato: in quegli anni le idee erano più vicine all’utopia che alla realtà. Ci furono anche le prime riunioni sindacali, dovevamo prendere coscienza dei nostri diritti: sindacalisti mai visti né conosciuti si accaloravano per noi come se fossimo vittime di chissà quale tirannia. D’istinto erano simpatici,
“Possiedo ancora una fotografia che mostra le baracche in costruzione alla sinistra di roulottes disposte a semicerchio e destinate a ospitare i ragazzi, sulla destra dell’immagine compare invece la jeep Fiat del direttore del campo.”
suscitavano approvazione e, vista la familiarità della situazione, ero tentato di chiedere: siamo trimestrali ben pagati, quale diritto ci è stato negato? Per fortuna non posi la domanda, sarebbe risultata ingenua e avrebbe suscitato ironie: a quell’epoca era assiomatico che un lavoratore fosse tiranneggiato dai padroni, solo i crumiri erano legittimati a sentirsi soddisfatti del loro lavoro.
Nel mese di Giugno il raffazzonato gruppo partì in pullman e, raggiunta Acceglio, tutto fu predisposto per la costruzione del campo. Io mi ritrovai nel gruppo “Baracche A”, quello di stampo religioso ortodosso. A dirigere i lavori era una coppia che, pur non sapendo da che parte girarsi, impartiva ordini severissimi: tu solleva quel carico, tu invece vieni qui e tu, che diamine, cosa fai con le mani in mano?!!! Fu così che io e Mirko, che in quel momento stavamo trasportando un asse di legno, ci guardammo per chiederci: cosa facciamo qui? Senza alcuna autorizzazione ci spostammo dunque nel gruppo B, quello più politicizzato degli autonomi, con i quali finii per fare amicizia. Le serate passavano in sedute di “autocoscienza” che a quell’epoca erano assai in voga. La conclusione dei lavori rivelò una scena impietosa: le baracche erano in piedi, sì, ma non avevano porte e finestre; il tetto inoltre era costituito da assi allineate, dalle cui fessure la prima pioggia sarebbe entrata allagando tutto. Possiedo ancora una fotografia che mostra le baracche in costruzione alla sinistra di roulottes disposte a semicerchio e destinate a ospitare i ragazzi, sulla destra dell’immagine compare invece la jeep Fiat del direttore del campo.
Si cercò di risolvere il problema della pioggia inchiodando teli di cellophane su tetto, porte e finestre. La pioggia non avrebbe così fatto il suo ingresso, questo era certo. Un amico, esperto di montagna, disse: gente, siamo a quasi duemila metri e di notte la temperatura è un po’ rigida. Niente paura, al termine di una improvvisata riunione si convenne che i sacchi a pelo tipo “mummia”, già in dotazione all’esercito, avrebbero fatto al caso nostro. Ognuno dormì dunque imbacuccato dentro un pesante sacco, disteso su materassi che il comune ligure aveva provveduto a inviarci e che presentavano vistose macchie di sangue un po’ dappertutto. Evidentemente, provenivano da qualche ospedale dismesso. Agli autonomi furono sufficienti pochi giorni per pronunciare la fatidica sentenza: trattasi di violazione dei diritti dei lavoratori. I materassi vennero, solo allora, sostituiti.
Il direttore della colonia, quello dallo spirito avventuroso, ci dava dei rammolliti girando spavaldo sulla sua jeep. Una sera un gruppo di ragazzi si era avviato verso la vallata oltre Chiappera, c’era buio e pioggia. Perché non fossero andati di giorno, non so. Il direttore si mise allora in contatto radio con il gruppo: qui parla campo base, dove siete? Risposta: siamo ormai al buio, inizia a piovere, i ragazzi hanno freddo. Vista la situazione precipitare, il direttore salì con slancio atletico sulla sua jeep e partì a tutta velocità per l’operazione di salvataggio. Quella scena ci divertì, ricordava quei film d’avventura che si concludevano al grido “Arrivano i nostri!”.
Quello che amavo fare durante quell’esperienza era portare i ragazzi in montagna. Noi monitori avevamo un rapporto di uno a otto che non rappresentava un problema. Per quanto fossero terribili, non era difficile gestire otto ragazzi. Anzi, anche quelli più scalmanati in montagna avevano una loro disciplina, soprattutto se responsabilizzati. Un giorno avevo affidato le riserve di cioccolata a uno di loro. Te la senti? Guarda che è una responsabilità! Con mia sorpresa, non venne a mancare neppure un quadretto. Un giorno portai i miei otto alle cascate dello Stroppia con l’obiettivo di dormire al bivacco Barenghi, a quasi 3000 metri, per poi raggiungere il confine francese il giorno dopo. Vennero anche due coraggiose ragazzine di dieci anni, bene accettate e rispettate dai loro pestiferi coetanei. Ragazze, guardate che ci sarà molto da camminare! Siamo sicure, vogliamo venire, dissero. Il sentiero iniziava subito a salire in mezzo ai larici ma non fu il pendio a spaventarci, bensì un ruscello che scendeva impetuoso dalle montagne e che pareva difficile da attraversare. Furono prime proprio le ragazze a notare una passerella nascosta nella vegetazione, pochi metri a monte del sentiero. Arrivammo così ai piedi della montagna dove una mulattiera saliva ripida con una serie di tornanti scavati nella roccia. L’esposizione era vertiginosa e io, io stavo molto attento ai ragazzi, mettere un piede in fallo avrebbe voluto dire precipitare. Finalmente, superato uno stretto intaglio nella roccia, sbucammo sullo spiazzo erboso proprio davanti al rifugio Stroppia. Era il momento di fare una sosta, di mangiare qualcosa e osservare quel panorama travolgente, nella sua solarità. Nei ragazzi c’era un’eccitazione che aumentò quando, poco oltre il rifugio, passammo il primo salto delle cascate su una passerella di legno. Eravamo in una nuvola d’acqua. Sbucammo allora in un vallone verdissimo al centro del quale vi era il Lago Niera nel quale si specchiavano, vanitose, quelle montagne di confine. Salimmo ancora in uno scenario in cui l’erba lasciava spazio ai detriti, enormi masse di roccia scese a valle da chissà dove e da chissà quanto. La giornata era alla fine. Ci si domandava dove fosse la nostra meta, il bivacco Barenghi. Quando già iniziavo a preoccuparmi, la sua struttura metallica, a forma di mezza botte, comparve all’improvviso dietro alcune rocce che la nascondevano allo sguardo. Tirammo un sospiro di sollievo, sistemammo i nostri zaini e ci cambiammo, preparando cena. Ma furono sufficienti pochi minuti di distrazione per permettere ai ragazzi di cacciarsi nei guai e, quando li vidi, stavano già arrampicandosi su un roccione davanti al laghetto antistante il bivacco. Feci cenni disperati richiamando il gruppo che rientrò indenne e incassò un severo rimprovero. All’arrivo del buio il tempo peggiorò, si scatenò un violento nubifragio e la pioggia, battendo sul tetto di lamiera, faceva un baccano d’inferno. Ognuno era, in silenzio, nella sua branda. E se cade un fulmine? La domanda era arrivata così, improvvisa, e nel buio, neppure sapevo chi l’avesse fatta. I fulmini, i fulmini cadono e scivolano sulle rocce, risposi. Ma il nostro bivacco è, sulle rocce! Vero anche questo, e quindi? Quindi l’elettricità provocata dal fulmine potrebbe arrivare fin qui. Sì, potrebbe arrivare fin qui. Se prima di questo dialogo c’era silenzio all’interno di quel bivacco, quel silenzio divenne ancor più profondo. Ma non dovete preoccuparvi, aggiunsi, nella vita un fulmine può colpirci sempre e ovunque. Anche in città? Anche in città, certo. Ma non ci sono fulmini in città! Certo che ci sono, è che qui, in questo silenzio, si sentono di più: ma voi cosa intendete dire con la parola “fulmine”? Fulmine, è qualcosa che ti colpisce, disse l’uno, allora anche una disgrazia è un fulmine, aggiunse l’altro. Proprio così, ragazzi, sono tanti tipi i fulmini quante le disgrazie che dobbiamo affrontare nella vita, ricordatevi di quello che ci siamo detti oggi. Ce ne ricorderemo, buonanotte. Buonanotte.
Il giorno dopo la pioggia era cessata ma le condizioni meteorologiche non facevano sperare in niente di buono e così rientrammo alla base. Il passaggio del confine era solo rinviato.
L’occasione arrivò quando la coppia ecumenica, quella che dirigeva il gruppo “Baracche A” mi chiese se fossi disponibile ad accompagnare un gruppo in Francia. Perché no? – risposi. Naturalmente la mia disponibilità irritò non poco la componente autonoma e peraia del campo, ma non importava, se si tratta di montagna bisogna essere disponibili, con tutti. La mia idea era di raggiungere il villaggio francese di Barcelonnette passando all’andata per il Colle delle Munie e al ritorno per il Col Sautron. In Francia avremmo chiesto al comune ospitalità per la notte. Il giorno della partenza il tempo era ottimo, il gruppo dei ragazzi numeroso ma felice. Ricordando quell’escursione credo, a distanza di tempo, che nel mio animo aleggiasse un inconsapevole senso di vendetta per l’atteggiamento che quell’altezzosa coppia di monitori aveva avuto nei confronti di tutti noi. L’occasione si verificò proprio al momento della salita che portava al colle e quindi sullo spartiacque che separava Italia e Francia. In un punto il terreno era franato e andare oltre poteva essere davvero un pericolo. In quella situazione, non so dire se per sicurezza dei miei mezzi o per perfida follia, io attraversai quel tratto scivoloso di sentiero con la stessa nonchalance con cui si passeggia la domenica sul marciapiedi di un lungomare. I due monitori, cui tremavano le gambe, mi guardarono allibiti. Allora puntai i piedi sul terreno e, attaccandomi alla roccia, feci passare, uno per uno, tutti i componenti della comitiva. Sul colle ci riposammo, mangiando qualcosa. Fu allora che quei due si avvicinarono e mi dissero: ma sei davvero bravo in montagna! Eh, risposi, mica per niente Francesco aveva segnalato il mio nome per il nostro campeggio. In realtà, forse ero stato semplicemente uno scriteriato, ma questo ovviamente non potevo dirlo.
Iniziò la discesa sul versante francese fino a quando, dall’alto, comparvero le prime case di Barcelonnette e, insieme a esse, la sagoma di un campo sportivo. Sfidiamo a calcio i francesi! – dissero delle voci in coro. Vorrei farvi presente che quando arriveremo giù, saranno ormai sette le ore di cammino percorse, siete sicuri di riuscire a giocare? La risposta era scontata e al calare delle prime ombre della sera, la sfida ebbe inizio. Al calcio non si resiste. In verità un campetto era anche vicino al campeggio di Acceglio, non si può dire quindi che quei ragazzi fossero in crisi di astinenza da arte pedatoria. Ma quel campo era della colonia dei padri Maristi i quali, uditi i miei smadonnanti ragazzi e considerata la loro insensibilità a qualsiasi giaculatoria, decisero di inviare lettera di formale protesta. Da quel giorno, addio campetto di calcio. La sfida coi francesi avrebbe colmato quel vuoto. La partita inizio alle prime ombre della sera.
Nella memoria rimane un terreno solo in parte erboso, con porte rudimentali e reti che terminavano a filo d’erba. Su quel terreno, sul far della sera, non c’erano giocatori ma ombre, ombre che si rincorrevano e che finivano per accasciarsi al suolo a ogni, inevitabile, scontro. Io ero una di quelle ombre, e trovavo un particolare piacere in quelle inutili rincorse nel fresco dell’erba, che respiravo a pieni polmoni dopo ogni caduta. Quella sera fummo ospitati nella palestra della scuola, dove disponemmo zaini e sacco a pelo, per poi consumare una cena molto frugale. Fu a quel punto che la coppia di monitori ecumenica, traumatizzata dall’esperienza, mi comunicò l’intenzione di ritornare con la corriera che dal confine francese avrebbe raggiunto Cuneo. Nooooooo!!! Ma come? Rinunciare a un’escursione in queste giornate di sole! Mi pareva un sacrilegio ma non ci fu niente da fare, il trauma era stato, evidentemente, forte. Dovevo tornare da solo con i ragazzi disposti a camminare ancora. Tornammo in quattro, salendo al col Sautron su prati dai fiori bianchissimi: poi una fotografia sulla cima del colle, poi la discesa in Italia, poi una bibita in una vecchia osteria, in una località di nome: Saretto.
Al ritorno notai non poca agitazione tra il personale. Era accaduto che un quotidiano di Genova aveva pubblicato un articolo sul nostro campeggio. Non si trattava di un articolo qualsiasi, era vistoso, su quattro colonne, e sbalorditivo nel titolo: Acceglio, pornocamping. Lessi quel pezzo tutto d’un fiato, volevo capire cosa potesse giustificare una notizia simile dato che, mai, avevo avuto la sensazione che qualcosa di anomalo fosse avvenuto nel corso di quell’esperienza. La lettura mi stupì: a ben vedere motivazioni non ce n’erano, se si esclude una frase sibillina che
“Nella memoria rimane un terreno solo in parte erboso, con porte rudimentali e reti che terminavano a filo d’erba. Su quel terreno, sul far della sera, non c’erano giocatori ma ombre.”

“Gattino invece lo rividi l’ultima volta nell’estate del 1982. Quella volta gli chiesi di parlarmi delle sue fotografie e lui mi raccontò di come aveva allestito una camera oscura con mezzi rudimentali. Si era tagliato la barba. Gli feci una fotografia, l’unica che oggi mi rimane di lui.”
recitava come “le docce fossero all’aperto e in promiscuità”. L’aggettivo “promiscuo” poteva in effetti suscitare torbide fantasie se non fosse che le docce all’aperto, in qualsiasi camping, al mare
come in montagna, sono costituite da una lunga pedana in legno dove ognuno, naturalmente in costume, si recava. Insomma, quell’articolo era un falso. Non ci volle molto a svelare l’arcano: il giornale che lo aveva pubblicato apparteneva a una gruppo politico di colore opposto a quello dell’amministrazione comunale. Era quindi evidente il tentativo di mettere in cattiva luce le iniziative proposte da quella amministrazione. Quello che tuttavia non avevo mai sperimentato è il grado di falsità che un giornalismo deteriore poteva raggiungere.
Uno dei problemi principali era dimostrare ai genitori che si trattava di una montatura, il rischio era di dover terminare anzitempo quell’esperienza. I rappresentanti comunali seppero però fornire le necessarie garanzie, alla fine tutti i ragazzi rimasero e l’esperienza del campeggio arrivò a compimento. Ricordo che l’ultima sera prima della partenza i ragazzini erano tristi e alcuni di loro mi fecero capire che si aspettavano da me un regalo. Donai ciò che possedevo, ad Ambrogio una maglietta e a Marina il cappellino di lana che indossavo durante le incursioni. Furono contenti, credo che per loro fosse importante conservare qualcosa che ricordasse quell’estate. Ricordo in particolare che andammo in una discoteca per giovanissimi, improvvisata nel garage dell’albergo “le Marmotte”. Un bambino di cui non ricordo il nome, che aveva forse sette anni e un ciuffo biondo sulla testa tonda, quasi a ricordare un personaggio dei fumetti, aveva indossato un foulard, al punto da somigliare a un dandy in miniatura. Faceva sorridere.
Oggi quei ragazzi avranno circa quarant’anni, non possiedo i loro nomi, che la memoria ha cancellato, e a volte mi domando dove saranno, cosa faranno. Gattino invece lo rividi l’ultima volta nell’estate del 1982. Quella volta gli chiesi di parlarmi delle sue fotografie e lui mi raccontò di come aveva allestito una camera oscura con mezzi rudimentali. Si era tagliato la barba. Gli feci una fotografia, l’unica che oggi mi rimane di lui. Quel giorno mi fece un rimprovero senza farlo apparire tale, era uno di quei vecchi saggi che ti permettono di comprendere le cose senza rivelarle mai esplicitamente. Qualche anno prima gli avevo chiesto due cucchiai da cucina da usare come percussioni durante una session collettiva: lui era al piano e tutti gli altri suonavano qualsiasi oggetto fosse in grado di emettere un suono. Quella volta, non gli restituii i due cucchiai al termine della serata e lui non se ne era dimenticato. Mi disse che alcuni giorni prima aveva ricevuto la visita di due alpinisti che non vedeva da molto tempo e che le parole “ritorno” e “restituzione”avevano per lui un significato speciale. Annuii. Il messaggio era chiaro e non lo dimenticai.
Non l’ho dimenticato neppure quando sono ritornato da lui nell’anno 2010. Da tanto tempo non mi recavo in Val Maira e di lui non avevo avuto più notizie. La valle mi è apparsa la stessa di un tempo: il fatto di non avere un transito di confine e neppure impianti per lo sci, l’aveva preservata dalla cementificazione. Ho rivisto anche il luogo in cui trent’anni prima era il nostro campeggio di Acceglio, un grande spiazzo nel quale l’erba non era più cresciuta. Anche Chiappera non era diversa da come la ricordavo e solo un sguardo ravvicinato mi ha permesso di capire che le case contadine di allora, erano state quasi tutte internamente ristrutturate. Il Provenzal City, con la sua insegna incisa su legno, era rimasta l’ultima abitazione del paese. Oltre, era la montagna, la montagna impervia delle cime Castello e Provenzale. Ho bussato, senza che nessuno venisse ad aprirmi. Sono tornato indietro e ho chiesto informazioni nell’unico posto pubblico di quella borgata, un bar che un tempo era anche trattoria. Gattino non c’è più, mi dicono, una malattia ai polmoni l’ha portato via, nel 1998. E le sue fotografie? Non so come, ma questa è l’unica domanda che ho trovato spontaneo fare. Le sue fotografie, venticinque in tutto, erano state esposte in altrettanti locali pubblici a partire da Villar San Costanzo, vale a dire nella parte alta della valle. Una mostra permanente destinata a durare, nel tempo.
Me ne sono andato. Con due cucchiai ancora in tasca, che avevo pensato di portare con me.
2 maggio 2025