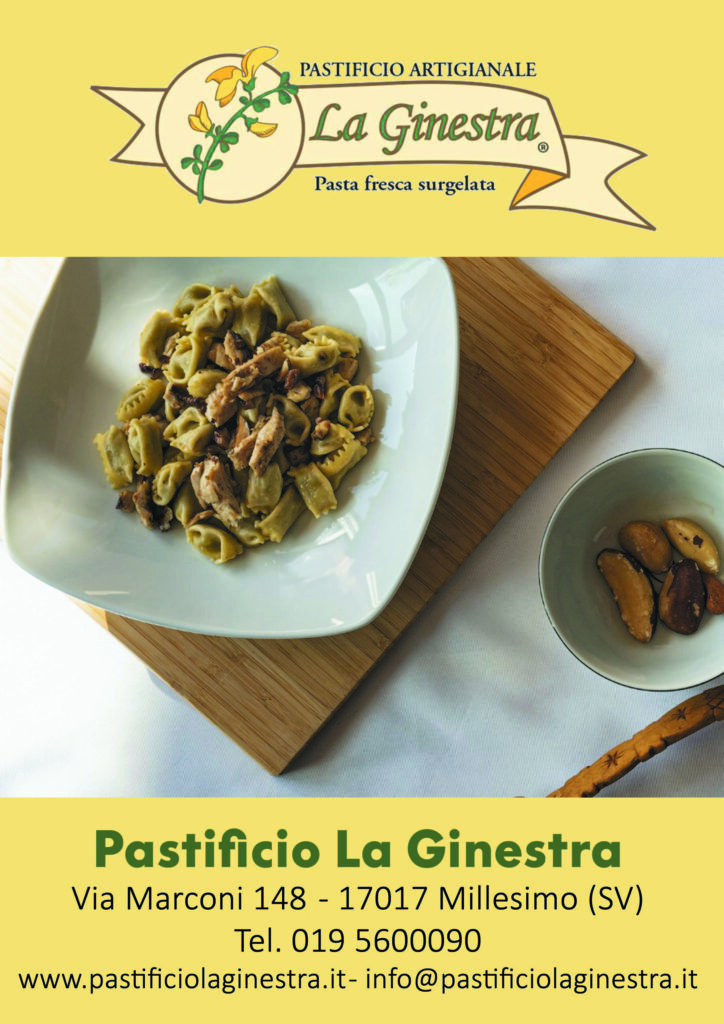di Clara Manca
In mezzo a tanti problemi che investono l’Italia, sta passando sotto silenzio quello riguardante la scuola. Sì, certo, in questi giorni se ne è parlato: il ministro Giuseppe Valditara ha messo in campo nuove direttive, che segnano – a suo dire – “un passaggio fondamentale per la costruzione di un sistema scolastico che responsabilizzi i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti”, come il cinque in condotta che può portare alla bocciatura. Ma sul cambiamento di approccio all’insegnamento delle discipline poco o niente si è discusso.
Le Nuove Indicazioni Nazionali, per il primo ciclo scolastico (non ancora legge), stese da una commissione diretta dalla professoressa Loredana Perla, forniscono seri motivi di perplessità a chi ha a cuore la formazione di cittadini autonomi e consapevoli. Vediamo perché, esaminando più da vicino l’insegnamento dell’Italiano.
Innanzitutto, bisogna qui precisare che le associazioni professionali del settore hanno ribadito con diversi documenti la non accettabilità del documento in questione, anche riguardo al proprio settore disciplinare (dalla Società di Linguistica Italiana al Movimento di Cooperazione Educativa, e al CIDI, fino al Giscel, sorto intorno alla figura di Tullio De Mauro). Le Nuove Indicazioni, oltre che per la loro natura “prescrittiva”, che non lascia spazio alle scelte didattiche dei docenti, stabilendo i contenuti linguistici e letterari da affrontare in classe, vengono respinte per la loro mancanza di rigore scientifico e l’ignoranza della situazione scolastica reale.
Per quanto riguarda il rigore scientifico, vi si ignorano i risultati della ricerca sull’educazione linguistica e letteraria dell’ultimo ventennio, nonché i più recenti documenti del Consiglio d’ Europa. Si nota un uso impreciso e confuso dei termini, come nel caso di abilità, competenza, conoscenza, e l’assenza di un quadro organico per l’insegnamento dell’Italiano come lingua seconda, per i tanti alunni con background migratorio. Viene presentata un’idea anacronistica di grammatica come sistema di regole certe e perenni, mentre viene prestata eccessiva attenzione alla correttezza formale, a discapito dell’adeguatezza comunicativa a seconda del contesto. Così, l’errore viene semplicemente individuato come “deviazione dalla norma”, invece che spia del processo di apprendimento in corso, come sostenuto dagli studi di settore da più di 50 anni!
Quanto alla Letteratura, essa è presentata come occasione di sviluppo del gusto alla lettura, in un approccio tendenzialmente passivo e mnemonico. Il suo insegnamento viene visto come momento di “formazione di un individuo che voglia definirsi civile” Ma, “civile” presume un’idea di civiltà ristretta, una visione normativa. E tutto ciò, a dispetto di un quadro metodologico di approccio al testo letterario, con il fine di permettere una sua comprensione e interpretazione.
Per ora, fermiamoci qui, lasciando da parte la scrittura (il “riassunto” al centro!), le altre abilità linguistiche messe ai margini (oralità e ascolto), l’educazione linguistica latina, la trasversalità dell’insegnamento dell’Italiano nelle diverse discipline, ecc., ecc.
9 maggio 2025