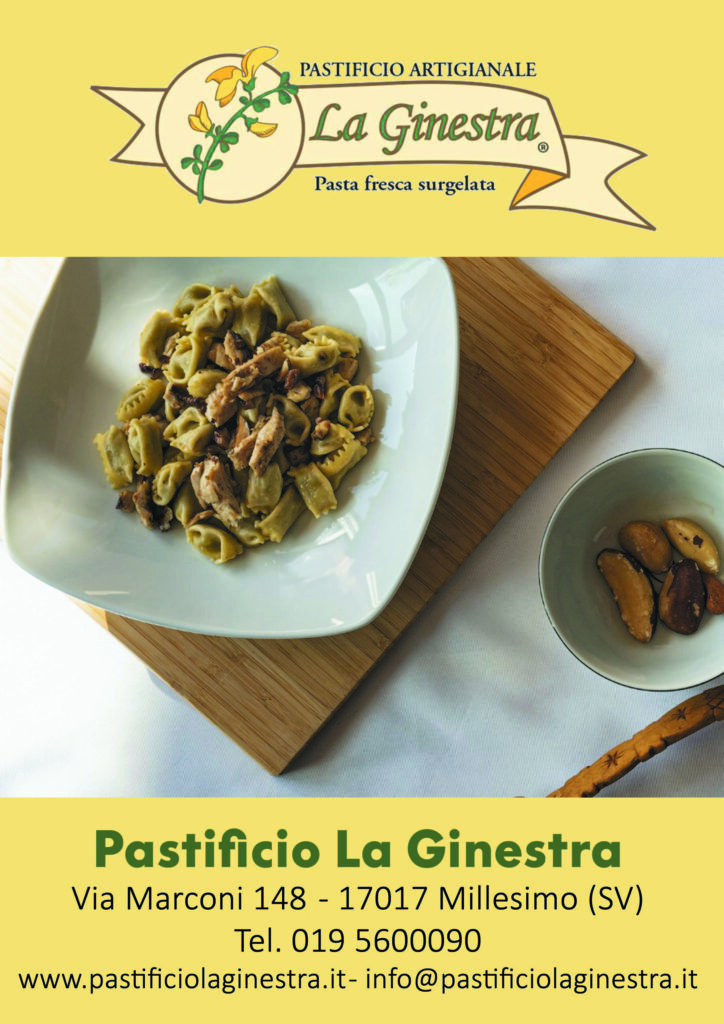di Chiara Giustini e Maya Dombrosa
Brani dal testo sacro e sconosciuto delle buone maniere
di Giovanni Della Casa
Giovanni Della Casa (1503-1556) scrisse il suo trattato di “belle maniere” fra il 1551 e 1554, mentre si trovava quasi esiliato nella Badia di Nervesa. Il Galateo fu pubblicato a Venezia, in un volume dal titolo Rime e prose e costituì una fortunata eccezione di sobrietà e leggerezza nella produzione fortemente e fieramente retorica di Monsignor Della Casa.
La agilità del testo e la ricchezza dei dettagli narrativi e descrittivi gli resero un immediato successo e ne fecero una sorta di prontuario di società molto popolare. Questo unire morale e comportamento, armonia del vivere civile e virtù si collegavano direttamente a quello che ancora per tutto il Cinquecento era considerato indirettamente un trattato di buone maniere, e cioè il Decameron, in particolare nelle novelle cortesi, nelle quali si esprimono continuamente i valori del ben vivere e del corretto relazionarsi. Un semplicistico slittamento fa sì che il Galateo sia considerato un insieme di precetti, un manuale di “etichetta”: ma anche la selezione che vi proponiamo vi dimostrerà quanto sotto ogni suggerimento si celi un’idea di armonia, come il rispetto dell’altro sia uno dei criteri fondamentali. Nella lettura del Galateo, inoltre, si cela il ritratto di una società in evoluzione, facilmente soggetta al ridicolo, non perché intrappolata in una etichetta superficiale, ma perché miope e piena di sé.
Introduzione
“Io incomincerò da quello che per aventura potrebbe a molti parer frivolo: cioè quello che io stimo che si convenga di fare per potere, in comunicando et in usando con le genti, essere costumato e piacevole e di bella maniera: il che non di meno è o virtù o cosa a virtù somigliante”.
Maniere
“Adunque, con ciò sia che le nostre maniere sieno allora dilettevoli, quando noi abbiamo risguardo all’altrui e non al nostro diletto, se noi investigheremo quali sono quelle cose che dilettano generalmente il più degli uomini, e quali quelle che noiano, potremo agevolmente trovare quali modi siano da schifarsi nel vivere con esso loro e quali siano da eleggersi.
Non solamente non sono da fare in presenza degli uomini le cose laide o fetide o schife o stomachevoli, ma il nominarle anco si disdice; e non pure il farle et il ricordarle dispiace, ma etiandio il ridurle nella imaginatione altrui con alcuno atto suol forte noiar le persone. E perciò sconcio costume è quello di alcuni che in palese si pongono le mani in qual parte del corpo vien lor voglia. Similmente non si conviene a gentiluomo costumato apparecchiarsi alle necessità naturali nel conspetto degli uomini; né, quelle finite, rivestirsi
nella loro presenza; né pure, quindi tornando, si laverà egli per mio consiglio le mani dinanzi ad onesta brigata, con ciò sia che la cagione per la quale egli se le lava rappresenti nella imagination di coloro alcuna bruttura. E per la medesima cagione non è dicevol costume, quando ad alcuno vien veduto per via (come occorre alle volte) cosa stomachevole, il rivolgersi a’ compagni e mostrarla loro. E molto meno il porgere altrui a fiutare alcuna cosa puzzolente, come alcuni soglion fare con grandissima instantia, pure accostandocela al naso e dicendo: – Deh, sentite di gratia come questo pute! -; anzi doverebbon dire: – Non lo fiutate, perciò che pute -. E come questi e simili modi noiano quei sensi a’ quali appartengono, così il dirugginare i denti, il sufolare, lo stridere e lo stropicciar pietre aspre et il fregar ferro spiace agli orecchi, e dèesene l’uomo astenere più che può. E non sol questo; ma dèesi l’uomo guardare di cantare, specialmente solo, se egli ha la voce discordata e difforme; dalla qual cosa pochi sono che si riguardino, anzi, pare che chi meno è a ciò atto naturalmente più spesso il faccia. Sono ancora di quelli che, tossendo e starnutendo, fanno sì fatto lo strepito che assordano altrui; e di quelli che, in simili atti, poco discretamente usandoli, spruzzano nel viso a’ circonstanti; e truovasi anco tale che, sbadigliando, urla o ragghia come asino; e tale con la bocca tuttavia aperta vuol pur dire e seguitare suo ragionamento e manda fuori quella voce (o più tosto quel romore) che fa il mutolo quando egli si sforza di favellare: le quali sconce maniere si voglion fuggire come noiose all’udire et al vedere. Anzi dèe l’uomo costumato astenersi dal molto sbadigliare, oltra le predette cose, ancora perciò che pare che venga da un cotal rincrescimento e da tedio, e che colui che così spesso sbadiglia amerebbe di esser più tosto in altra parte che quivi, e che la brigata, ove egli è, et i ragionamenti et i modi loro gli rincrescano”.
7 maggio 2025
- Continua