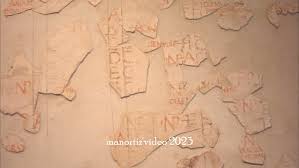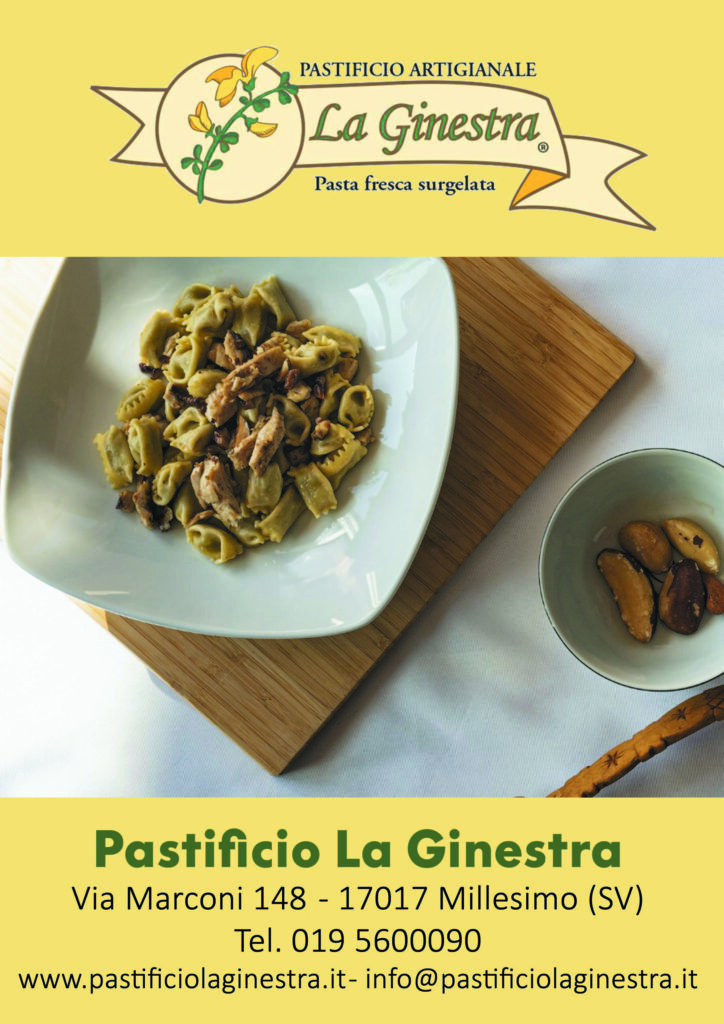di Marzia Codella
Per capire il nostro presente, le nostre tradizioni abbiamo bisogno di conoscere il nostro passato! sono tantissime le parole, i gesti, i rituali che compiamo ogni giorno e che traggono la loro origine in esso. Poichè siamo nel periodo in cui finisce l’anno e ne inizia uno nuovo è l’occasione giusta per conoscere l’origine del nostro calendario. La parola calendario, trae origine dal latino arcaico kalendai e da un latino classico Kalendae.
La calenda era il primo giorno di ciascun mese ed era un giorno importante, non solo perchè consacrato a Giunone ma anche perchè il Pontifex Maximus in questo giorno annunciava al popolo romano, convocato in assemblea presso la Curia Calabra (luogo di culto dove nella Roma antica si osservava la Luna Nuova), la data delle feste, dei giochi, dei giorni fasti (leciti per svolgere attività pubblica e amministrare la giustizia, non essendoci impedimenti di carattere religioso) e di quelli nefasti (a carattere espiatorio, dedicati alla religione) che ricorrevano durante il mese. Ed era anche il momento in cui i debitori avrebbero dovuto estinguere i loro debiti elencati nel calendarium, il libro dei conti. Dunque i romani non utilizzavano il termine calendario per indicare la scansione annuale del tempo, ma il termine Fasti (da dies fasti). Le tabulae su cui venivano riportati erano esposte alle Kalendae Martiis (calende di Marzo, all’inizio dell’anno, mese del risveglio della natura e della ripresa di tutte le attività).
Il “calendario romano” ha subito nel tempo un’evoluzione dettata dal graduale aumento delle necessità di precisione nel calcolo del tempo, in base alla sempre crescente complessità della società romana in ambito economico, civile, politico e religioso. Per comprendere ciò dobbiamo tenere presente che in antico non esisteva quella dicotomia fra Religione e Stato che caratterizza invece la nostra società moderna. Ogni azione umana aveva un presupposto religioso ed era impossibile stabilire una netta divisione tra festa religiosa e festa civile. Ogni avvenimento politico richiedeva di necessità la consultazione del parere divino, così come ogni evento pubblico o privato era sottolineato da una cerimonia religiosa e civile insieme. Il calendario romano dunque conteneva tutte le notizie astronomiche, agrarie e religiose di ciascun mese e anche la deità sotto la cui protezione era posto il mese.
La prima forma di calendario (Macrobio Saturnalia, Prima Giornata, I, 12.39; Ovidio, Fasti, III, 415-417) è attribuita a Romolo, il primo re di Roma, utilizzato dalla fondazione 753 a.C.. Era un calendario di tipo lunare. Aveva inizio con Marzo e terminava dieci mesi dopo; seguiva poi un periodo in cui non si calcolava il tempo fino al Marzo successivo. In questo calendario le Kalendae corrispondevano alla fase di Luna Nuova, le Nonae a quella di Primo Quarto e le Idi a quella di Luna Piena. Le Nonae erano il giorno del mese che cadeva nove giorni prima delle Idi (i Romani contavano sia il giorno in cui si cominciava a contare sia quello in cui finiva il conto). Le Calende e le Idi erano sempre dies fasti (consacrati rispettivamente a Giunone e Giove), le None non erano consacrate a nessun dio. Il giorno successivo alle Calende, alle Nonae e alle Idi era considerato giorno sfortunato (dies ater, cioè nero). Nefasti erano anche i dies religiosi o vitiosi (giorni ritenuti superstiziosi in ricordo di gravi calamità).
I primi mesi prendevano il nome dalle principali divinità legate alle attività umane: Martius (dedicato a Marte, dio della guerra) e proseguiva con Aprilis (dall’aprirsi dei germogli delle piante, era il mese dedicato a Venere), Maius (dedicato a Maia, madre di Mercurio; o ai maggiori, i romani adulti), Junius (dedicato a Giunone o ai minori, i giovani atti alle armi), Quintilis (quinto mese, poi mutato in Julius, in onore di Giulio Cesare nel 44 a.C.), Sextilis (sesto, poi mutato in Augustus, in onore di Ottaviano Augusto, nell’8 a.C.), September (settimo mese), October (ottavo mese), November (nono mese), December (decimo mese).
Ovviamente questo tipo di calendario lunare, per il fatto che vi era un periodo in cui il tempo non veniva contato, creava dei problemi in termini temporali, di conseguenza nel 713 a.C. Numa Pompilio rinnovò questo calendario aggiungendo due mesi, Jannuarius (dedicato a Janus, Giano) e Februarius (riservato al sacrificio di espiazione, Februa, per le anime dei morti), e portandolo a 355 giorni (Livio Ad Urbe Condita I, 19).
Per far coincidere questo calendario con quello lunare (motivo per cui lo si definisce Luni-Solare) veniva inserito generalmente ad anni alterni il mese Mercedonius, prima di Marzo, della durata di 27 giorni. Di conseguenza il calendario negli anni intercalari risultava di 377 o 378 a seconda che il Mercedonius fosse fatto iniziare prima o dopo i Terminalia (23 febbraio), e che quindi 5 giorni (circa) potevano sovrapporsi agli ultimi di febbraio. La decisione di inserire il mese intercalare spettava al Pontifex Maximus. Non è nota la posizione esatta di Kalendae, Nonae e Idi in questo tipo di calendario.
Nel tempo però la necessità di organizzare i lavori agricoli durante le varie stagioni, spinse ad usare l’anno solare. Sarà la riforma di Giulio Cesare a correggere l’errore di datazione che si era comunque venuto a creare di ben 85 giorni con il precedente sistema. Eliminò il Mercedonius, ristabilì i giorni dei mesi così come li conosciamo oggi, ed introdusse l’anno bisestile. In questo calendario Kalendae, Nonae e Idi sono disposte come segue: le Kalendae sempre il 1° del mese; le Nonae cadevano, in marzo, maggio, luglio e ottobre, al. settimo giorno del mese, negli altri mesi al quinto; le Idi cadevano otto giorni dopo le Nonae, quindi nei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, al 15; negli altri mesi al 13.
Il calendario giuliano venne adottato fino all’ottobre del 1582 quando, con la bolla Inter gravissimas, papa Gregorio XIII, promulgò l’adozione di un nuovo calendario, chiamato appunto “gregoriano”, il calendario che oggi è in vigore nella maggior parte del mondo occidentale. Il 5 ottobre del 1582,, divenne nel calendario giuliano il 15 ottobre. L’anno durò quindi una decina di giorni in meno, salto necessario per riallineare il calcolo dei giorni del calendario con l’anno solare. L’obiettivo del calendario gregoriano era rimettere ordine nella scansione e nel calcolo del tempo, adottando un sistema più preciso rispetto al precedente, suddividendo l’anno in 12 mesi con durate diverse, da 28 a 31 giorni, per un totale di 365 giorni e di 366 nel caso degli anni bisestili.
Marzia Codella, ricercatrice del Cnr
Anna Perenna e il capodanno dei romani
Fuori da Porta Flaminia, su una collina localizzabile oggi sui monti Parioli, vi era il bosco (lucus) sacro di Anna Perenna la dea della natura e del rinnovarsi delle stagioni. In questo lucus durante le Idi di Marzo (13-15 del mese) veniva celebrata la divinità e con lei il primitivo capodanno romano (“Nelle Idi si celebra la gioiosa festa di Anna Perenna non lontano dalle tue rive, o Tevere forestiero”, Ovidio, Fasti, III, 523-542). Durante questa festa era possibile fare tutto quello che in città era considerato inopportuno o vietato. Si allestivano banchetti lungo la via Flaminia e si passava la giornata sotto capanni e tende, ricollegandosi ad una civiltà pre-urbana e pre-romana; le donne danzavano con i capelli sciolti, all’epoca impensabile, poichè il rituale del matrimonio prevedeva che la madre della sposa glieli raccogliesse in una treccia già dalla sera prima delle nozze; imitavano ciò che avevano visto a teatro, quando calcare le scene significava perdere all’istante lo status di uomo libero; e soprattutto facevano gare di bevute, perché secondo la tradizione ogni coppa di vino tracannata avrebbe loro prolungato la vita di un anno. Si dava dunque sfogo a grandi manifestazioni di allegria e intrattenimento con balli, canti osceni, e sesso. Una festa irresistibile a cui partecipavano tutti, tanto è vero che questa data fu scelta per uccidere Cesare proprio perché Roma era deserta.
Tradizionalmente Anna Perenna (dea del nutrimento e dell’abbondanza) è raffigurata con un fascio di spighe tra le mani ed era non di rado, associata ad altre figure mitologiche, o con una figlia d’Atlante. Era soprattutto un simbolo augurale. La sua festa coincideva con il preludio di primavera ed era quindi un auspicio alla buona stagione contadina. Per gli antichi romani era anche la manifestazione della Luna Piena e, per estensione, dei cicli lunari e del trascorrere delle stagioni. Era “colei che nutre”o “colei che è piena di cibo”. L’epiteto“Annapurna” venne di fatto adeguato nella storia a figure femminili che richiamavano alla mente il dono della fecondità, come la Diana di Efeso “dalle mille mammelle”, e – nel mondo cristiano – la Vergine Maria, dichiarata ad Efeso stessa “Theotokos” (generatrice di Dio, non solo di un uomo).
La radice sanscrita “ann” (cibo) riappare nel termine latino “Annona”, ovvero nell’antichità le scorte di cibo da utilizzare in caso di carestia o assedio. In qualunque modo sia giunta nel Lazio, questa divinità testimonia la presenza della Dea Madre in tempi arcaici, quando il suo culto legato alla terra e alla fertilità, era sentito e onorato anche in Italia. È probabile però che nei secoli, questo primitivo significato sia andato mano a mano dissolvendosi, e che il popolo romano abbia unito l’idea di avere una dea che nutriva e che si occupava dell’intero ciclo dell’anno, con l’etimologia di “annus“, facendo di lei una divinità dell’anno ritornante. Durante la sua festa ci si augurava a vicenda :”ut annare perennareque commode liceat”(Macrobio,Saturn., I, 12, 6), dove per annare si deve intendere l’entrare nel nuovo anno e col perennare il condurre a buon fine quello uscente. L’altra etimologia “amnis perennis” ne fece anche un nume tutelare delle acque, ossequiata in una fonte di Roma, segno tangibile che il senso arcaico del mito non era più compreso. Da Dea dell’abbondanza e dello scorrere del tempo a Ninfa ambigua e misteriosa che pone in contatto con l’aldilà e con gli dei Inferi. In questa evoluzione del culto di Anna Perenna possono aver anche influito le narrazioni costruite dagli storici e dai poeti. Ovidio ci lascia alcune versioni del mito di Anna Perenna per spiegarne le origini. La prima la identifica con la sorella della regina cartaginese Didone, Anna, che dopo la tragica morte di questa per sfuggire al fratello Pigmalione, trovò accoglienza a Malta, presso la corte del Re Batto (dove per altro il culto della Dea Madre è stato molto sentito e ha lasciato numerose testimonianze). Costretta però a prendere di nuovo il mare, fece naufragio sulle coste del Lazio e venne ospitata da Enea ma dovette fuggire nuovamente perchè ostacolata dalla gelosia di Lavinia. Durante la fuga Anna scivolò nel fiume Numicus (oggi Fosso di Pratica di Mare, un piccolo fiume che scende dal Monte Albano, passa per Lavinio e sfocia nel Mar Tirreno) ed affoga diventando una Ninfa delle acque e facendo udire in perpetuo la sua voce con le “onde perenni” (amne perenne). Un’altra variante giustificherebbe il clima lubrico dei festeggiamenti in suo onore. Il dio Marte, invaghitosi di Minerva, chiese aiuto alla dea perché intercedesse in suo favore; Marte fu dunque invitato ad un alcova segreta con un appuntamento, ma anzichè trovare la bella Minerva, si vide comparire dinanzi il volto della vecchia Anna Perenna, che lo derideva sbeffeggiandolo.
Nel 1999 durante gli scavi per un parcheggio interrato all’angolo tra piazza Euclide e via G. Dal Monte, nel quartiere Parioli a nord di Roma, fu rinvenuta la fontana di Anna Perenna. Lo scavo era diretto dall’archeologa Marina Piranomonte della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ed è stato effettuato ad una profondità compresa tra circa i 6 e i 10 metri dal piano stradale. Dall’argilla e dal fango emerse quel che resta di una fontana rettangolare, con un’ara e due basi con iscrizioni e una data: “nimphis sacratis Annae Perennae“- alle ninfe consacrate ad Anna Perenna – 156 d.C. sotto la guida dell’Imperatore Antonino Pio. L’analisi delle muratura rilevò un utilizzo almeno dal IV secolo a.C. fino al VI secolo d.C.. La struttura della fontana era di tipo greco, il flusso idrico fuoriusciva attraverso delle fistulae da protomi decorativi a testa di animale, previo passaggio in una cisterna di decantazione retrostante, dotata, alla sommità, di uno sfioramento che permetteva all’acqua in eccesso di ricadere nella vasca sottostante. Veniva così garantita la purezza dell’acqua attinta per usi alimentari mentre il supero veniva recuperato in fase di uscita, per altre necessità, come l’abbeverata animale o gli usi agricoli. I materiali recuperati dallo scavo testimoniano come il culto della dea-ninfa Anna Perenna si sia trasformato, in epoca tardo imperiale, in qualcosa di oscuro e misterioso Nella cisterna retrostante la fontana sono stati trovati nel fango rappreso, svariati oggetti utilizzati per pratiche magiche e riti religiosi, come 550 monete che si gettavano lì per buon augurio, gusci d’uovo simbolo di fertilità, pigne, rametti e tavolette di legno, 70 lucerne, un paiolo in rame, 14 contenitori di piombo contenenti figurine antropomorfe e circa 22 defixiones (laminette in piombo con maledizioni e fatture). Ogni contenitore ne conteneva altri due (tre, numero magico), tutti sigillati con resine; il più esterno non presentava segni grafici, in quello mediano cominciavano ad apparire lettere e simboli magici, mentre il più piccolo conteneva la fattura scritta e una figurina antropomorfa impastata di miele, acqua e farina, infilata a testa in giù. Molti anni di restauro e di raggi infrarossi ci sono voluti per srotolare le defixiones in piombo e per aprire i coperchi sigillati dei contenitori.
E’rilevante il fatto che le figurine siano state ritrovate quasi intatte, quando nel clima umido di Roma, al contrario dell’Egitto, il materiale organico non resiste al tempo. Se i materiali di Anna Perenna si sono salvati, invece, è proprio grazie alla triplice sigillatura dei contenitori. Resta comunque un ultimo quesito ,ovvero quale fosse la funzione di quei contenitori in piombo, prima di essere riciclati per maledizioni e fatture. Questi oggetti sono oggi conservati nella Sezione Epigrafica del Museo Nazionale Romano presso le Terme di Diocleziano.
23 aprile 2025